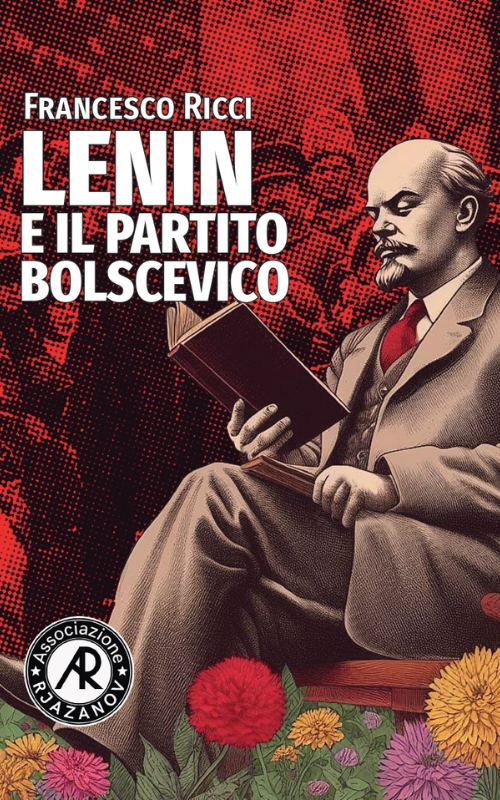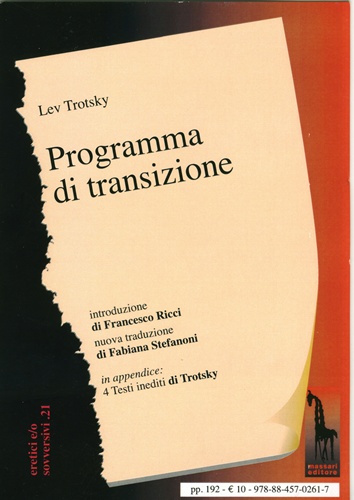L’imperialismo in Medio Oriente
Guerra e resistenza: Irak, Libano, Palestina
Alberto Madoglio
Il susseguirsi sempre più frenetico di avvenimenti tragici in Medio Oriente ci ha spinto a riservare, negli ultimi mesi, una particolare attenzione, nelle pagine del nostro giornale e nel sito web, a quella che è un’area strategica per le sorti della lotta di classe internazionale.
Occorre fare una premessa: più è stato grande lo sforzo delle varie potenze imperialiste internazionali negli ultimi anni – specialmente negli ultimi mesi – per arrivare ad una “normalizzazione” della situazione mediorientale, cioè per assestare un colpo mortale alle varie lotte di liberazione nazionale e di emancipazione sociale che lì si susseguono ininterrottamente da un secolo, più grande è stato il fallimento che questi tentativi hanno prodotto.
In particolare, abbiamo visto che i paesi imperialisti, Usa in testa, hanno profuso sforzi straordinari per far valere la loro politica neocoloniale in Palestina, Iraq e Libano; ebbene, proprio in questi tre paesi, le grandi potenze occidentali sono andate ad infilarsi in un pantano dal quale è sempre più difficile districarsi. La situazione irakena va sempre più deteriorandosi per gli americani e per i loro alleati locali, rappresentati dal governo fantoccio di Maliki e la vittoria dei democratici alle elezioni di ottobre non ha cambiato il carattere aggressivo della politica estera americana.
Il piano Baker
L’ultima novità, infatti, è il cosiddetto “Piano per il disimpegno irakeno” elaborato dalla commissione Baker (vecchio collaboratore dei Bush, avvocato di famiglia e membro dello staff di Bush padre alla Casa Bianca tra la fine degli anni ’80 e l’inizio degli anni ’90).
Le proposte avanzate in questo studio prevedono una riduzione, in tempi non definiti, della presenza di truppe americane nel paese (ne rimarrebbe comunque un numero considerevole, circa 75.000), una modifica del loro ruolo (supporto ad una più decisa presenza militare e di polizia locale), e la convocazione di una conferenza regionale per cercare di coinvolgere Iran e Siria nella soluzione del problema iracheno (ma anche in Palestina e Libano).
La Casa Bianca è incline a rifiutare questa proposta che, pur trattandosi solo di un’operazione di maquillage diplomatico che non andrebbe a modificare nella sostanza la politica guerrafondaia e neocolonialista di Washington, sancirebbe la fine della politica fin qui seguita dai neoconservatori e dal presidente Bush. Riconoscere che tre anni di guerra al terrore non hanno dato i risultati sperati e iniziare ad intessere un lavoro diplomatico con due “stati canaglia” come i regimi di Teheran e Damasco, è un prezzo che l’amministrazione americana non può né vuole pagare, anche perché una tale scelta rafforzerebbe di molto le posizioni delle potenze imperialiste europee, col rischio di vedere ridimensionato il peso politico globale di quella che è ancora vista come l’unica superpotenza rimasta.
Contro il piano Baker si sono pronunciati anche il premier israeliano Olmert e quello iracheno Maliki (che sa benissimo di non potersi fidare di forze militari locali e di dovere la sua sopravvivenza, non solo politica, ad una massiccia presenza di truppe straniere).
Le ragioni per cui l’esecutivo di Tel Aviv vede come fumo negli occhi ogni ipotesi di disimpegno americano nella regione sono alla base delle ultime mosse politiche riguardo alla questione palestinese.
Una premessa: al di là delle dichiarazioni propagandistiche, è senso comune, in Israele, che la guerra estiva contro Hezbollah si sia chiusa con una sconfitta. Olmert e i suoi alleati (i laburisti di Peretz e il semi fascista Lieberman) sono consci di non poter reggere a lungo una situazione di “quasi guerra” su tre fronti; delegato agli Usa il controllo dell’Iran per concentrarsi sul nemico a nord (Siria ed Hezbollah), è necessario chiudere una volta per tutte i conti con la questione palestinese. Le ultime dichiarazioni fatte dall’esecutivo sionista, circa la disponibilità di riconoscere uno Stato Palestinese, non devono trarre in inganno.
Sconfitta l’idea di occupare perennemente Gaza e Cisgiordania, ora tutte le forze vanno verso la ricerca di un accordo con l’ala più capitolazionista della società palestinese, Al Fatah. Il partito di Abu Mazen ha ormai abbandonato ogni velleità di lottare per i diritti del suo popolo: ha riconosciuto Israele e accetterebbe la nascita di uno stato fantoccio, non solo riconoscendo i confini del 1967 (dimenticando che l’occupazione sionista della Palestina nasce almeno dagli anni ’30), ma anche le migliaia di colonie costruite in barba agli stessi accordi di Oslo del 1993 (accordi che già di per sé hanno rappresentato il tradimento di decenni di lotta coraggiosa di diverse generazioni di palestinesi). Per non parlare di quella che è la vera questione fondamentale per i palestinesi, cioè il ritorno dei profughi e il controllo delle risorse vitali per le popolazioni di quelle aree, prima di tutto l’acqua. Questa volontà si sta scontrando in maniera sempre più aperta con quella che ad oggi è la rappresentanza politica maggioritaria tra il popolo, Hamas, che pur opponendosi alla politica del presidente dell’Autorità nazionale Palestinese, non propone una vera alternativa allo status quo.
La formula inventata dai suoi leader per differenziarsi da Al Fatah, senza però impegnarsi fino in fondo in una lotta senza quartiere al bastione dell’imperialismo in medio oriente, è quella della “tregua” decennale con Israele, la hudna.
Secondo i loro auspici questo escamotage semantico consentirebbe di non essere accomunati a Fatah nella politica di cedimenti a Tel Aviv, mantenendo – solo propagandisticamente – tutte le rivendicazioni storiche della resistenza palestinese all’occupazione e, allo stesso tempo, di proporsi come unico interlocutore con Israele. Questa lotta tra le due maggiori fazioni politiche del popolo palestinese ha subito, mentre scriviamo, una forte drammatizzazione. Il presidente dell’Anp, forte del sostegno di Israele e degli Usa, ha indetto nuove elezioni per il rinnovo del Parlamento, controllato da Hamas. Si tratta di un autentico colpo di stato, che rischia di far precipitare il paese verso un’aperta guerra civile. In questo confronto i comunisti si devono opporre con tutti i mezzi al golpe di Abu Mazen sostenuto dall’imperialismo.
Il Libano chiave di volta della situazione mediorientale
Ma oggi la chiave di volta di tutta la situazione mediorientale è il Libano. Dopo la guerra dello scorso luglio, che ha visto i miliziani di Hezbollah resistere ai furiosi attacchi di dell’esercito israeliano, la politica libanese ha subito forti scossoni.
Il governo filo imperialista di Siniora, consapevole dell’aumento di prestigio goduto dall’organizzazione dello sceicco Nasrallah tra le masse diseredate del paese, non solo di religione sciita, e contando in caso di estremo bisogno sulla presenza di truppe imperialiste nel paese pronte a correre in suo aiuto, sta cercando in ogni modo di eliminare un avversario politico per lui sempre più pericoloso. L’occasione è stata la modifica costituzionale per permettere la creazione del cosiddetto “Tribunale Hariri”, che dovrebbe indicare i colpevoli dell’omicidio dell’ex premier libanese morto in un attentato quasi due anni fa. Hezbollah, ovviamente, si è opposto a questa decisione, in quanto è evidente a tutti che la sentenza di questa “corte indipendente” è già scritta: Hezbollah e Siria sono responsabili e quindi vanno puniti. Da qui la crisi di questi giorni con le dimissioni dei ministri di Hezbollah e dei suoi alleati dal governo, la richiesta della formazione di un governo di unità con una maggiore rappresentanza di ministri di questo partito ed una nuova riforma elettorale che premi il consenso che dopo luglio Hezbollah ha anche tra settori cristiani e sunniti della popolazione.
Tuttavia, più profondi sono i motivi dello scontro in atto; in questi giorni il governo di Siniora ha presentato un piano economico, chiamato "Paris 3", basato su privatizzazioni di tutte le aziende pubbliche, distruzione dello stato sociale, aumento delle tasse indirette e relativa diminuzione di salari e pensioni, scritto sotto dettatura della Banca Mondiale.
Questo piano ha contribuito a scatenare le proteste che hanno portato alla manifestazione di due milioni di persone (in un paese che conta quattro milioni di abitanti!) contro il governo, e all’assedio, per ora pacifico, della sede del potere a Beirut, il palazzo del Gran Serraglio.
Questa enorme mobilitazione ci dimostra due cose: la prima è che per l’imperialismo non sarà così facile imporre le proprie politiche ultra liberiste nel paese dei cedri e la seconda è che alle masse libanesi occorre una direzione politica alternativa. Hezbollah, come tutte le organizzazioni islamiste, basate su un programma reazionario piccolo borghese, tende a cercare un accordo con l’imperialismo e con i suoi portavoce locali. Nel caso specifico, invece di dirigere la lotta in senso rivoluzionario, propone un nuovo esecutivo in cui possa avere un numero maggiore di ministri. Se ciò avvenisse, non sarebbero gli alleati delle grandi potenze mondiali ad aver ceduto alle forze più radicali, ma il contrario. Una versione mediorientale della Grosse Koalition oggi al potere in Germania, farebbe scelte di chiara natura di classe, anti popolare, così come quelle imposte a Berlino da Cdu e Spd. La crisi oggi in corso in Libano non potrà finire senza vincitori né vinti: o dalla mobilitazione nascerà un’organizzazione basata su un programma marxista rivoluzionario, fondata sull’indipendenza politica del proletariato libanese, in grado di rovesciare il dominio delle classi possidenti del paese, oppure le masse popolari subiranno una sconfitta di proporzioni storiche.
Dicembre 2006
Guerra e resistenza: Irak, Libano, Palestina
Alberto Madoglio
Il susseguirsi sempre più frenetico di avvenimenti tragici in Medio Oriente ci ha spinto a riservare, negli ultimi mesi, una particolare attenzione, nelle pagine del nostro giornale e nel sito web, a quella che è un’area strategica per le sorti della lotta di classe internazionale.
Occorre fare una premessa: più è stato grande lo sforzo delle varie potenze imperialiste internazionali negli ultimi anni – specialmente negli ultimi mesi – per arrivare ad una “normalizzazione” della situazione mediorientale, cioè per assestare un colpo mortale alle varie lotte di liberazione nazionale e di emancipazione sociale che lì si susseguono ininterrottamente da un secolo, più grande è stato il fallimento che questi tentativi hanno prodotto.
In particolare, abbiamo visto che i paesi imperialisti, Usa in testa, hanno profuso sforzi straordinari per far valere la loro politica neocoloniale in Palestina, Iraq e Libano; ebbene, proprio in questi tre paesi, le grandi potenze occidentali sono andate ad infilarsi in un pantano dal quale è sempre più difficile districarsi. La situazione irakena va sempre più deteriorandosi per gli americani e per i loro alleati locali, rappresentati dal governo fantoccio di Maliki e la vittoria dei democratici alle elezioni di ottobre non ha cambiato il carattere aggressivo della politica estera americana.
Il piano Baker
L’ultima novità, infatti, è il cosiddetto “Piano per il disimpegno irakeno” elaborato dalla commissione Baker (vecchio collaboratore dei Bush, avvocato di famiglia e membro dello staff di Bush padre alla Casa Bianca tra la fine degli anni ’80 e l’inizio degli anni ’90).
Le proposte avanzate in questo studio prevedono una riduzione, in tempi non definiti, della presenza di truppe americane nel paese (ne rimarrebbe comunque un numero considerevole, circa 75.000), una modifica del loro ruolo (supporto ad una più decisa presenza militare e di polizia locale), e la convocazione di una conferenza regionale per cercare di coinvolgere Iran e Siria nella soluzione del problema iracheno (ma anche in Palestina e Libano).
La Casa Bianca è incline a rifiutare questa proposta che, pur trattandosi solo di un’operazione di maquillage diplomatico che non andrebbe a modificare nella sostanza la politica guerrafondaia e neocolonialista di Washington, sancirebbe la fine della politica fin qui seguita dai neoconservatori e dal presidente Bush. Riconoscere che tre anni di guerra al terrore non hanno dato i risultati sperati e iniziare ad intessere un lavoro diplomatico con due “stati canaglia” come i regimi di Teheran e Damasco, è un prezzo che l’amministrazione americana non può né vuole pagare, anche perché una tale scelta rafforzerebbe di molto le posizioni delle potenze imperialiste europee, col rischio di vedere ridimensionato il peso politico globale di quella che è ancora vista come l’unica superpotenza rimasta.
Contro il piano Baker si sono pronunciati anche il premier israeliano Olmert e quello iracheno Maliki (che sa benissimo di non potersi fidare di forze militari locali e di dovere la sua sopravvivenza, non solo politica, ad una massiccia presenza di truppe straniere).
Le ragioni per cui l’esecutivo di Tel Aviv vede come fumo negli occhi ogni ipotesi di disimpegno americano nella regione sono alla base delle ultime mosse politiche riguardo alla questione palestinese.
Una premessa: al di là delle dichiarazioni propagandistiche, è senso comune, in Israele, che la guerra estiva contro Hezbollah si sia chiusa con una sconfitta. Olmert e i suoi alleati (i laburisti di Peretz e il semi fascista Lieberman) sono consci di non poter reggere a lungo una situazione di “quasi guerra” su tre fronti; delegato agli Usa il controllo dell’Iran per concentrarsi sul nemico a nord (Siria ed Hezbollah), è necessario chiudere una volta per tutte i conti con la questione palestinese. Le ultime dichiarazioni fatte dall’esecutivo sionista, circa la disponibilità di riconoscere uno Stato Palestinese, non devono trarre in inganno.
Sconfitta l’idea di occupare perennemente Gaza e Cisgiordania, ora tutte le forze vanno verso la ricerca di un accordo con l’ala più capitolazionista della società palestinese, Al Fatah. Il partito di Abu Mazen ha ormai abbandonato ogni velleità di lottare per i diritti del suo popolo: ha riconosciuto Israele e accetterebbe la nascita di uno stato fantoccio, non solo riconoscendo i confini del 1967 (dimenticando che l’occupazione sionista della Palestina nasce almeno dagli anni ’30), ma anche le migliaia di colonie costruite in barba agli stessi accordi di Oslo del 1993 (accordi che già di per sé hanno rappresentato il tradimento di decenni di lotta coraggiosa di diverse generazioni di palestinesi). Per non parlare di quella che è la vera questione fondamentale per i palestinesi, cioè il ritorno dei profughi e il controllo delle risorse vitali per le popolazioni di quelle aree, prima di tutto l’acqua. Questa volontà si sta scontrando in maniera sempre più aperta con quella che ad oggi è la rappresentanza politica maggioritaria tra il popolo, Hamas, che pur opponendosi alla politica del presidente dell’Autorità nazionale Palestinese, non propone una vera alternativa allo status quo.
La formula inventata dai suoi leader per differenziarsi da Al Fatah, senza però impegnarsi fino in fondo in una lotta senza quartiere al bastione dell’imperialismo in medio oriente, è quella della “tregua” decennale con Israele, la hudna.
Secondo i loro auspici questo escamotage semantico consentirebbe di non essere accomunati a Fatah nella politica di cedimenti a Tel Aviv, mantenendo – solo propagandisticamente – tutte le rivendicazioni storiche della resistenza palestinese all’occupazione e, allo stesso tempo, di proporsi come unico interlocutore con Israele. Questa lotta tra le due maggiori fazioni politiche del popolo palestinese ha subito, mentre scriviamo, una forte drammatizzazione. Il presidente dell’Anp, forte del sostegno di Israele e degli Usa, ha indetto nuove elezioni per il rinnovo del Parlamento, controllato da Hamas. Si tratta di un autentico colpo di stato, che rischia di far precipitare il paese verso un’aperta guerra civile. In questo confronto i comunisti si devono opporre con tutti i mezzi al golpe di Abu Mazen sostenuto dall’imperialismo.
Il Libano chiave di volta della situazione mediorientale
Ma oggi la chiave di volta di tutta la situazione mediorientale è il Libano. Dopo la guerra dello scorso luglio, che ha visto i miliziani di Hezbollah resistere ai furiosi attacchi di dell’esercito israeliano, la politica libanese ha subito forti scossoni.
Il governo filo imperialista di Siniora, consapevole dell’aumento di prestigio goduto dall’organizzazione dello sceicco Nasrallah tra le masse diseredate del paese, non solo di religione sciita, e contando in caso di estremo bisogno sulla presenza di truppe imperialiste nel paese pronte a correre in suo aiuto, sta cercando in ogni modo di eliminare un avversario politico per lui sempre più pericoloso. L’occasione è stata la modifica costituzionale per permettere la creazione del cosiddetto “Tribunale Hariri”, che dovrebbe indicare i colpevoli dell’omicidio dell’ex premier libanese morto in un attentato quasi due anni fa. Hezbollah, ovviamente, si è opposto a questa decisione, in quanto è evidente a tutti che la sentenza di questa “corte indipendente” è già scritta: Hezbollah e Siria sono responsabili e quindi vanno puniti. Da qui la crisi di questi giorni con le dimissioni dei ministri di Hezbollah e dei suoi alleati dal governo, la richiesta della formazione di un governo di unità con una maggiore rappresentanza di ministri di questo partito ed una nuova riforma elettorale che premi il consenso che dopo luglio Hezbollah ha anche tra settori cristiani e sunniti della popolazione.
Tuttavia, più profondi sono i motivi dello scontro in atto; in questi giorni il governo di Siniora ha presentato un piano economico, chiamato "Paris 3", basato su privatizzazioni di tutte le aziende pubbliche, distruzione dello stato sociale, aumento delle tasse indirette e relativa diminuzione di salari e pensioni, scritto sotto dettatura della Banca Mondiale.
Questo piano ha contribuito a scatenare le proteste che hanno portato alla manifestazione di due milioni di persone (in un paese che conta quattro milioni di abitanti!) contro il governo, e all’assedio, per ora pacifico, della sede del potere a Beirut, il palazzo del Gran Serraglio.
Questa enorme mobilitazione ci dimostra due cose: la prima è che per l’imperialismo non sarà così facile imporre le proprie politiche ultra liberiste nel paese dei cedri e la seconda è che alle masse libanesi occorre una direzione politica alternativa. Hezbollah, come tutte le organizzazioni islamiste, basate su un programma reazionario piccolo borghese, tende a cercare un accordo con l’imperialismo e con i suoi portavoce locali. Nel caso specifico, invece di dirigere la lotta in senso rivoluzionario, propone un nuovo esecutivo in cui possa avere un numero maggiore di ministri. Se ciò avvenisse, non sarebbero gli alleati delle grandi potenze mondiali ad aver ceduto alle forze più radicali, ma il contrario. Una versione mediorientale della Grosse Koalition oggi al potere in Germania, farebbe scelte di chiara natura di classe, anti popolare, così come quelle imposte a Berlino da Cdu e Spd. La crisi oggi in corso in Libano non potrà finire senza vincitori né vinti: o dalla mobilitazione nascerà un’organizzazione basata su un programma marxista rivoluzionario, fondata sull’indipendenza politica del proletariato libanese, in grado di rovesciare il dominio delle classi possidenti del paese, oppure le masse popolari subiranno una sconfitta di proporzioni storiche.
Dicembre 2006