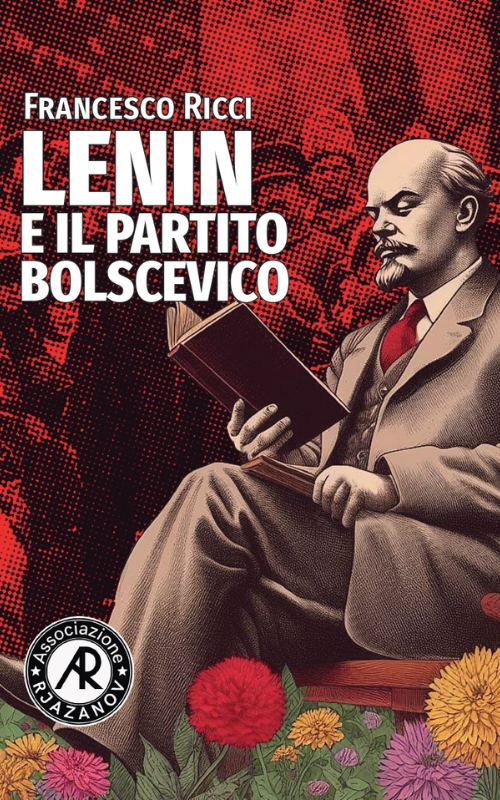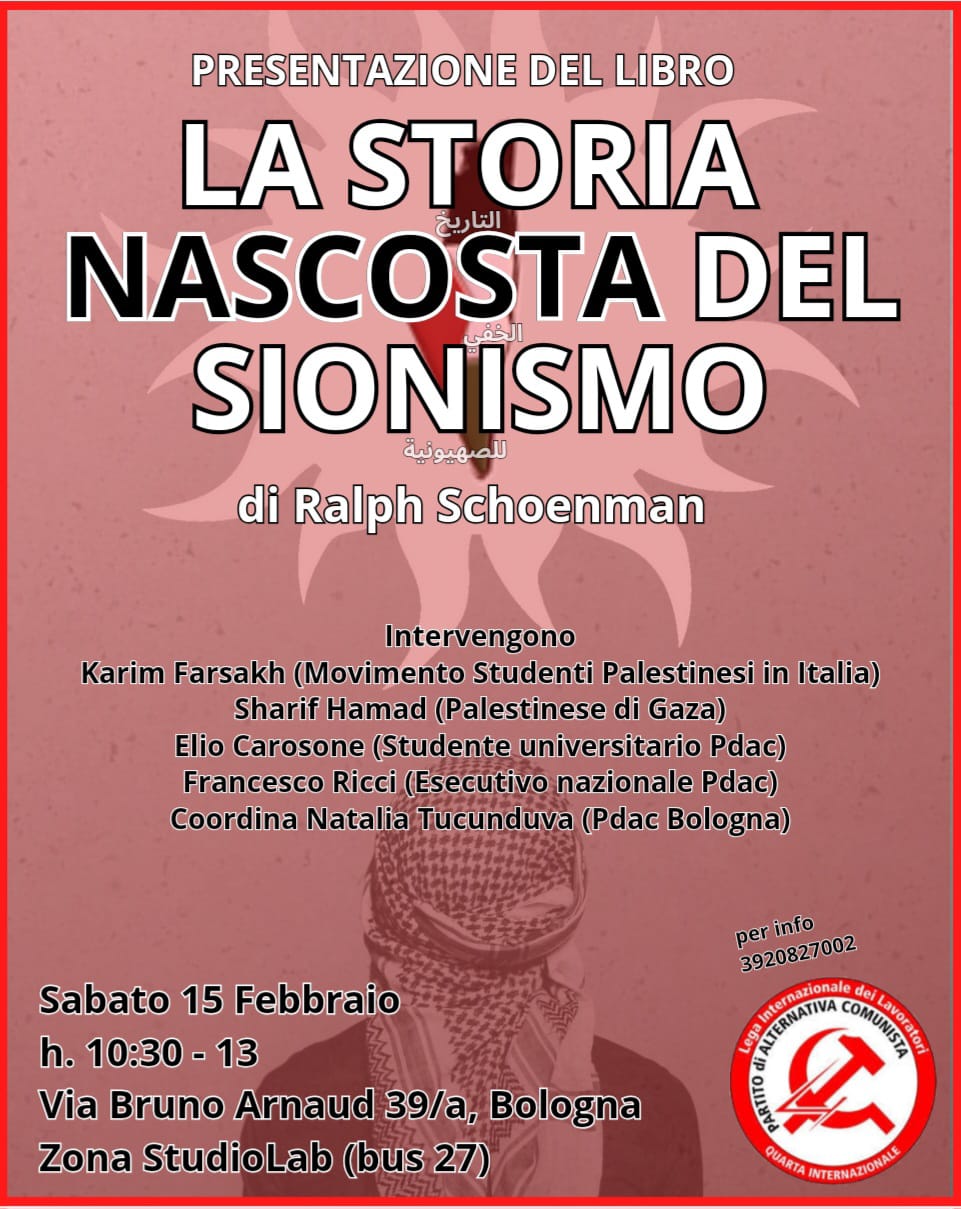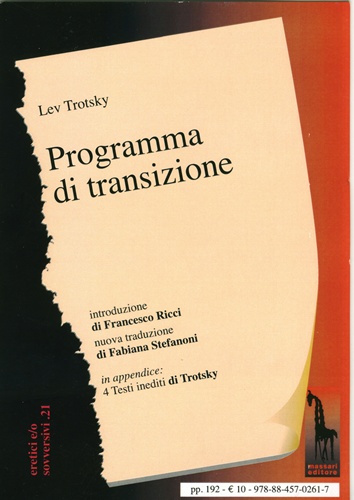I MARXISTI E LA CRISI DEL CAPITALISMO
Documento sull'analisi economica della fase
Ne Il Capitale, la sua opera più importante dedicata allo studio
dell'economia capitalistica, Marx analizza i tratti fondamentali delle crisi
cicliche del capitalismo:
1) Il capitalismo si caratterizza
per essere un'economia che produce merci;
ovvero, valori destinati alla vendita
sul mercato.
2) Nella produzione di merci, solo
la forza-lavoro crea valore nuovo. I
macchinari e le materie prime si limitano a restituire il loro valore
consumato.
3) Per questo, Marx distingue
l'investimento che effettua la borghesia in capitale
variabile o "v" (salari per
acquistare forza-lavoro) e capitale
costante o "c" (per l'acquisto
degli altri fattori produttivi).
4) I capitalisti si appropriano di
una frazione del valore nuovo prodotto dalla forza-lavoro poiché retribuiscono
solo una parte di esso, corrispondente al salario. Questa frazione non
retribuita Marx la chiama plusvalore.
5) Il plusvalore si estrae dalla
produzione e si realizza sul mercato con la vendita delle merci diventando così
la fonte del profitto dei capitalisti (l'aumento
del capitale investito attraverso la capitalizzazione del plusvalore).
6) I capitalisti misurano il
risultato dei loro investimenti attraverso il tasso di profitto. Ovvero, l'aumento del capitale investito dopo la
chiusura del circolo produzione-vendita-capitalizzazione del plusvalore.
7) La concorrenza porta i
capitalisti ad investire in maniera crescente nei macchinari e nella tecnologia
per produrre di più e a minor costo. Cioè, tendono ad aumentare la parte del
capitale costante (c) e a diminuire quella del capitale variabile (v). Queste
diverse relazioni tra c e v determinano quella che Marx definisce
la composizione organica del capitale.
8) L'aumento della parte di capitale
costante permette, nella fase iniziale, un aumento del tasso di profitto.
Questi elementi (aumento simultaneo degli investimenti e del tasso di profitto)
costituiscono i tratti centrali della fase
ascendente dei cicli dell'economia capitalista.
9) Successivamente, tuttavia, il
tasso di profitto comincia a diminuire, in un processo che Marx studia nella
sua legge della caduta tendenziale del
saggio di profitto.
10) Con la caduta del tasso di
profitto, i capitalisti cominciano a diminuire i propri investimenti. Si
manifesta così il punto di svolta che inizia la fase discendente dei cicli economici (o crisi ciclica). Le crisi economiche sono, dunque, intrinseche al
sistema capitalistico e alla sua struttura di funzionamento.
11) Con l'inversione di tendenza, la
caduta del tasso di profitto è l'essenza
di tutte le crisi capitalistiche. Tuttavia, questa essenza si rende visibile
attraverso la forma di una crisi di
sovrapproduzione, ovvero, cominciano ad apparire merci che non trovano sbocchi
sul mercato, non trovano acquirenti. L'avvento del capitale finanziario, in
epoca imperialistica, ha fatto si che certe crisi possano manifestarsi dapprima
come crisi finanziarie, cioè, nel
mercato dei capitali, o combinandosi tra queste e la sovrapproduzione di merci.
Ma in tutti i casi, la fonte di tutte le crisi è la caduta del saggio di
profitto.
12) Allo stesso tempo, le stesse
crisi generano meccanismi per
superare, per un periodo, le cause che le provocano: distruzione di capitali
(serrate di imprese) e diminuzione di salari col ricatto della disoccupazione,
aumentando così il tasso di plusvalore estratto dalla forza-lavoro. Inoltre, il
capitalismo ha dato vita a tutta una serie di altri meccanismi per attenuare o evitare la caduta del tasso di profitto:
centralizzazioni sempre più grandi delle imprese, sfruttamento di altri Paesi,
l'intervento dello Stato ecc. Tuttavia, l'unico dispositivo che può sostenere
il tasso di profitto in maniera consistente è l'aumento del plusvalore assoluto, cioè un aumento dei ritmi di
produzione e di sfruttamento dei lavoratori più grande dell'investimento totale
del capitale.
L'ANALISI FATTA DA MARX DELLE LEGGI FONAMENTALI CHE REGOLANO IL CAPITALISMO SONO ATTUALI PIU' CHE MAI E CI AIUTANO, FUORI DA OGNI VISIONE IMPRESSIONISTA, A CAPIRE GLI SCONVOLGIMENTI CHE STANNO ATTRAVERSANDO L'ECONOMIA MONDIALE
La crisi che sta travolgendo ormai da quasi due anni
l'economia capitalista a livello mondiale sta facendo piazza pulita di tutte le
teorie che, in special modo dopo il crollo del muro di Berlino, prevedevano che
il capitalismo sarebbe stato l'unico sistema politico, economico e sociale in
grado di garantire il benessere per l'intera umanità.
Oggi vediamo quanto quegli auspici fossero falsi, quanto
quella pressante propaganda fosse basata su una errata interpretazione della
realtà. I fatti parlano chiaro. Nessun ramo dell'economia è esente dalla crisi
che infatti ha colpito sia la finanza che la produzione vera e propria. Non
solo il capitalismo "anglosassone", quello che normalmente viene considerato
maggiormente speculativo e ultraliberale, ma anche quello tradizionalmente
chiamato "renano" - e che secondo qualcuno dovrebbe essere più attento alla
giustizia e alla pace sociale (caratteristico dell'Europa continentale) - ha
dimostrato il suo fallimento.
Sono fallite o sono in enorme difficoltà non solo le banche
che più hanno fatto uso degli strumenti tipici della finanza creativa (Merryl
Linch, Lehman Brothers) ma anche quelle che si pregiavano di seguire un'impostazione
più classica, prudente, nei loro affari (come la banche italiani, francesi e
tedesche).
Stiamo assistendo al crollo della produzione e degli
investimenti sia nei settori più "maturi" dell'economia di mercato (produzione
acciaio, elettrodomestici, auto ecc.) sia in quelli innovativi, che fino a
qualche tempo fa venivano indicati come la base per garantire una crescita
senza fine dell'economia (internet, telecomunicazioni, software e hardware
informatico, ecc.).
Il fatto che la crisi, come detto in precedenza, sia
globale, abbia colpito le maggiori potenze imperialiste, così come i Paesi in
via di sviluppo o i cosiddetti Bric (brasile, Russia, India Cina), che, pur
avendo inizio nel settore immobiliare americano, non sia stata circoscritta ad
esso, ma si sia rapidamente propagata ai mercati azionari, alla finanza e alla
produzione manifatturiera dimostra come oggi ci troviamo di fronte ad una crisi
del capitalismo nel suo complesso.
Negli ultimi tempi, tuttavia, si comincia a sentire qualche
voce ottimista sul futuro. L'amministratore delegato della Fiat, ad esempio, ha
detto che il peggio è alle spalle. Alcuni dati statistici (contenuti aumenti
del Pil negli ultimi trimestri 2009
in Usa e altri Paesi) sembrano suffragare questi
auspici. Tuttavia, a un'analisi più accurata, possiamo affermare che questi
dati non indicano l'inizio di un'inversione di tendenza, ma sono solo normali
fluttuazioni all'interno di un ciclo che rimane in profonda recessione.
Nel 2009 il Pil mondiale è calato (tra lo 0,5 e l'1,5%) per
la prima volta dal dopoguerra. Particolarmente pesante è stata la contrazione per
Giappone e Germania (- 5%) e USA (-2,8%). Dopo un decennio di crescita a due
cifre la Cina
aumenterà il PIL del 7%. Assisteremo ad un'esplosione del deficit di bilancio
di molti Stati (per gli Usa si prevede un deficit di 1800 miliardi di dollari,
pari al 13% del PIL) così come dell'indebitamento sovrano degli stati (nel 2010
vi saranno nuove emissioni di titoli di stato per oltre 2000 miliardi i di
dollari).
Se a ciò aggiungiamo che Banca del Giappone, Federal Reserve
(FED) e Bank of England (BOE) hanno azzerato il tasso di sconto (facilitando i
deboli segnali di ripresa di cui sopra), che FED e BOE hanno dato il via a
quella che gli economisti chiamano "quantitive
easing" cioè alla stampa di nuova moneta (col rischio che tutto ciò crei
nuove tendenze inflazioniste), che necessariamente anche la BCE dovrà seguirle in questa
strada per evitare un eccessivo rafforzamento dell'Euro e quindi una perdita di
competitività delle merci europee, possiamo affermare che la luce in fondo al
tunnel della crisi al momento non è ancora visibile.
LA SITUAZIONE ITALIANA: NON UN CASO A SE', MA IL FRUTTO DELLO SVILUPPO DI UNA POTENZA IMPERIALISTA NEL QUADRO DELL'ECONOMIA GLOBALIZZATA
Anche l'Italia, come ormai tutti i Paesi del mondo, è
entrata in una profonda recessione economica, dalla quale, a differenza di
altri Paesi, le sarà più complicato uscire, per vari fattori che rendono oggi
il Belpaese l'anello più debole della catena imperialista mondiale.
Per diverso tempo il primo ministro Berlusconi e il suo ministro
delle finanze Tremonti hanno cercato di negare prima e minimizzare poi gli
effetti della crisi, iniziata con lo scoppio della bolla immobiliare negli Usa,
sull'economia italiana.
A giustificazioni di queste analisi, hanno usato argomenti
di vecchia data: hanno affermato che l'Italia non sarebbe caduta in recessione
per il fatto di essere poco sviluppata e non completamente integrata nel
circuito economico finanziario internazionale, per il fatto che le banche e le
industrie nazionali non si erano lanciate negli anni passati in operazioni di
speculazione finanziarie come viceversa hanno fatto i loro concorrenti
stranieri, che grazie a tutto ciò il Paese sarebbe stato solo sfiorato dalla
peggiore tempesta economica degli ultimi decenni.
Si tratta come detto di argomenti già usati in passato. Il
mito di una nazione nella quale il percorso di modernizzazione politico,
economico e sociale, non è stato mai completato è servito in passato al Partito
Comunista Italiano (nella sua versione stalinista ortodossa sia in quella più
soft dell'Eurocomunismo) per giustificare la politica di fronte popolare, di
alleanze tra gli operai e la borghesia democratica, al fine di "completare
la rivoluzione democratica del Paese", relegando le rivendicazioni
socialiste alla liturgia delle ricorrenze principali del movimento operaio. Ma
argomenti simili sono stati usati anche da settori della destra (non solo
quella fascista ma anche liberale) nel secolo scorso per unire attorno a sé gli
strati popolari del Paese, in rivendicazioni nazionaliste in cui la nazione
operaia e contadina italiana rivendicava il suo posto al tavolo delle maggiori
potenze imperialiste.
Queste previsioni, o meglio questi desideri, hanno lasciato
presto il posto alla realtà. L'Italia nel nel 2009 è stata in recessione
economica e per il 2010 le previsioni dei maggiori centri di studio non
lasciano molte speranze per una ripresa significativa.
D'altronde, che la rappresentazione autarchica del Paese sia
del tutto falsa lo dimostra il fatto che le maggiori imprese, banche e
assicurazioni italiane negli anni si sono impegnate in una fortissima
espansione internazionale: dalla Fiat che ha fabbriche nei quattro angoli del
pianeta, alle banche Unicredit e Intesasanpaolo, che hanno nei fatti
monopolizzato i mercati est europei, all'Eni e all'Enel che sono tra i maggiori
attori nel mercato globale del petrolio e dell'energia elettrica.
Sulle possibilità di una ripresa economica, e su quanto
questa possa essere strutturale e non congiunturale, dipende ovviamente da vari
fattori, ma per l'Italia le difficoltà rischiano di essere maggiori che per
altri Paesi.
Le politiche degli ultimi anni, in particolare quelle
iniziate all'epoca dell'ultima recessione economica del 1993, hanno certamente
permesso alle classi dominanti del Paese di ottenere delle grandi vittorie a
spese delle classi subalterne. L'ingresso nell'Euro è la migliore
rappresentazione di questo successo. Tuttavia, questo non ha risolto alcuni
problemi di fondo della struttura economico finanziaria del Paese, che la crisi
attuale rischia di far emergere in maniera prepotente. Prima di tutto bisogna
rilevare che il bilancio statale continua a essere in una condizione difficile,
tale da rendere l'Italia un'osservata speciale da parte di tutti gli istituti
finanziari internazionali. Quest'anno è previsto un deficit di bilancio del 5% che,
pur essendo fuori dai parametri di Maastricht, di per sé non è, per i tecnocrati
dell'Unone Europea, particolarmente rilevante, visto che in situazioni simili
si troveranno diversi Paesi della zona euro. Tuttavia è il dato relativo al
debito pubblico quello che desta le maggiori preoccupazioni. Nel 2009 è tornato
a salire prepotentemente, arrivando al 120% del PIL, con quali conseguenze è
facile prevedere. Questa situazione rischia di avere altri gravi effetti:
1) Lo Stato italiano rischia il default anche nel caso una
sola asta di titoli pubblici fallisca o le sottoscrizioni siano inferiori a
quanto offerto. Non è solo un'ipotesi di scuola: una cosa simile è capitata
all'inizio del 2009 a
un'asta dei titoli di stato tedeschi e a metà marzo in Gran Bretagna. Se
aggiungiamo che nel corso del 2010 ci sarà un'enorme offerta di titoli
governativi a livello mondiale, a causa della ingente richiesta di capitali
necessari ai vari governi per finanziare i loro tentativi di allentare i morsi
della crisi, c'è il rischio di gravi tensioni per il governo di Roma. Un
eventuale fallimento del cosiddetto "debito sovrano" di alcuni Paesi
(Grecia in testa) - possibile anche se improbabile - non potrà non avere
ripercussioni anche per i conti pubblici nazionali.
2) Oggi il voto che le agenzie di rating danno al debito
italiano è uno dei più bassi tra i Paesi avanzati. Altre bocciature rischierebbero
di far saltare le casse pubbliche. Questo comporta che il governo italiano si
trova in grosse difficoltà nel concedere tutti quei finanziamenti necessari per
salvare le imprese. Attualmente sono state stanziate cifre molto inferiori
rispetto a quanto hanno fatto altri Paesi. Questo sta rendendo molto nervosi e
critici gli industriali italiani, che, quando si tratta della difesa dei loro
profitti, diventano i maggiori sostenitori dell'intervento statale, aborrito
quando invece serve per cercare di difendere operai, studenti e disoccupati.
Anche la struttura economica nazionale rende le prospettive
di ripresa più incerte rispetto alle altre potenze imperialiste. Circa il 90%
delle imprese nazionali sono di piccole o piccolissime dimensioni. Questo va ad
influire su diversi aspetti, come la capacità di fare un investimento per
aumentare la produttività del lavoro, ottenere finanziamenti dalle banche a
condizioni favorevoli, ecc.
Per quanto concerne la produttività, i dati sono indicativi.
Pur avendo una media di ore lavorate per addetto superiore rispetto alla media
dei Paesi OCSE (1824 contro 1794), la produttività media oraria è aumentata nel
quinquennio 2001-2006 solo dello 0,5%, a fronte di una media dell'1,5.
Infatti negli ultimi anni il capitalismo italiano ha puntato
prevalentemente sullo sfruttamento feroce dei lavoratori - piuttosto che su
investimenti in tecnologia che aumentassero la produttività lavorativa - e su
attività economiche gestite in regime di monopolio quasi assoluto, grazie alla
assenza di concorrenza straniera (gestione delle autostrade, servizi
telefonici, di erogazione di luce, acqua, gas, energia elettrica e anche di
servizi finanziari a imprese e cittadini) i cui prezzi applicati hanno
garantito enormi profitti.
Tuttavia, in una situazione simile si trovano anche aziende
multinazionali che sono considerate il fiore all'occhiello del Paese. Le
acciaierie Riva, ad esempio, che sono tra i maggiori produttori di acciaio al
mondo, hanno però un tipo di produzione qualitativamente bassa, il che li rende
competitivi con quelle produzioni dei Paesi meno avanzati industrialmente e che,
allo stesso tempo, possono avere il vantaggio di una manodopera meno cara e
numericamente superiore rispetto a quella del loro concorrente italiano,
rendendo la produzione di quest'ultimo maggiormente a rischio.
La stessa Fiat, che negli ultimi tempi era stata portata ad
esempio di come un nuovo management aziendale potesse risollevare un'azienda in
crisi, è oggi in una situazione assai meno florida di come la si vorrebbe
rappresentare.
Secondo uno studio di CSM Worldwide, la capacità produttiva
delle sue fabbriche in Europa passerà dal 70,3% del 2008 al 63,9% del 2009, e
in particolare le 5 fabbriche italiane producono grossomodo lo stesso numero di
autovetture del solo stabilimento polacco. Se aggiungiamo che la sua produzione
è stata molto più bassa dei suoi concorrenti, anche negli anni passati, quando
il mercato dell'auto ha beneficiato di un boom come non si vedeva da anni,
possiamo intuire che in quegli anni è stata meno in grado di altri di
beneficiare di una situazione favorevole.
Ecco perché, secondo alcuni analisti, il valore di Fiat,
escluso il settore camion e macchine per l'agricoltura, è uguale a zero, e la fusione
con l'americana Chrysler, la più in crisi delle Big Three di Detroit, appare
come un disperato tentativo di salvare il salvabile.
Anche per il settore finanziario, che negli ultimi tempi
aveva dato vita a una serie di concentrazioni e fusioni, con la creazione di
veri e propri "campioni nazionali" in grado di competere con gli istituti
bancari esteri per la conquista dei mercati globali, le cose non vanno affatto
bene.
Unicredit, che per lungo tempo era diventato l'emblema della
finanza italiana nel mondo, è il simbolo di questa situazione. Nel corso del 2009 ha visto crollare il
suo valore di borsa e un peggioramento degli indici patrimoniali, tanto che il
suo fallimento è stato per lungo tempo all'ordine del giorno. Ora la situazione
sembra essere migliorata, anche grazie a due aumenti di capitale di circa 10
miliardi di euro, ma ciò nonostante la banca di Piazza Cordusio risulta ancora
nella lista delle 20 banche mondiali a maggior rischio di bancarotta. Discorso
simile per l'altra grande banca, Intesasanpaolo, che ha dovuto annullare la
distribuzione del dividendo agli azionisti, al fine di rientrare nei parametri
contabili stabiliti dai trattati di Basilea. In una situazione peggiore si
trovano anche banche come il Banco Popolare Italiano e il Monte dei Paschi
(roccaforte della cosiddetta finanza rossa, in quanto i suoi dirigenti sono
nominati dalle amministrazioni locali della città di Siena, governata dal
Partito Democratico), che avevano concentrato i loro affari prevalentemente in
Italia, a riprova che la crisi colpisce non solo chi internazionalizza la
propria attività.
Da ultimo, la stessa composizione del PIL non fa ben sperare
per il futuro. Negli ultimi anni, è stato grazie alle esportazioni (che valgono
circa il 20% del prodotto interno lordo) che l'economia italiana ha retto, seppur
con molte difficoltà.
Oggi però questo rischia di essere un elemento di debolezza
più che di forza. Intanto, perché anche altri Paesi che hanno fatto dell'export
il loro punto di forza (Germania e Cina) sono quelli che subiranno un maggior
rallentamento della crescita, in quanto uno dei risultati della crisi in corso
è che vi saranno una contrazione del commercio mondiale e uno stimolo a tendenze
protezionistiche nei vari Paesi.
In secondo luogo, perché l'Italia ha primeggiato in settori
"deboli" dal punto di vista tecnologico (abbigliamento, tessile, alimentare)
mentre ormai è debole (meccanica) o completamente assente da quelli più
avanzati (chimica, farmaceutica ed elettronica, produzione di satelliti ad uso
civile ecc.), quindi, come ricordavamo poco sopra, dovrà subire la feroce
concorrenza di Paesi che possono beneficiare di un'enorme manodopera a buon
mercato (agenzie internazionali stimano che l'export italiano tornerà a livelli
pre-crisi solo fra 15-20 anni).
SOLO LA LOTTA DI CLASSE INTERNAZIONALE, DIRETTA DA UN PARTITO CONSEGUENTEMENTE COMUNISTA, PUO' DARE UNA RISPOSTA PROGRESSIVA PER I LAVORATORI
In conclusione, l'uragano che sta devastando l'economia
mondiale sta mettendo a rischio la tenuta dell'impalcatura dell'egemonia
capitalista. Oltre alla possibilità concreta di vedere in breve tempo svanire
la concordia, molto di facciata, che ha caratterizzato i rapporti tra le varie
potenze negli ultimi venti anni (basti pensare alle accuse circa una mancanza
di scelte politiche incisive per affrontare la crisi, rivolte dagli Usa
all'Europa; le tensioni tra gli stessi Paesi della UE, i duri proclami della
burocrazia restaurazionista cinese contro le tendenze protezioniste della Casa
Bianca), assistiamo anche a una ripresa della conflittualità di classe a
livello mondiale.
Francia, Spagna, Portogallo e Grecia sono oggi le punte avanzate
di questa ripresa della conflittualità operaia. A breve una situazione simile
potrà verificarsi in Italia, Germania, Gran Bretagna, America Latina, Africa e
nello stesso epicentro della crisi, gli Usa. Compito di un'organizzazione
rivoluzionaria è quello di incanalare l'enorme rabbia popolare che già oggi
colpisce le persone e i simboli del capitalismo (le cronache ci raccontano di
sequestri di manager di multinazionali a opera di lavoratori licenziati, di
assalti alle abitazioni dei banchieri che si sono arricchite speculando sui
risparmi dei lavoratori, ecc.) verso un fine più ampio, pur se molto difficile:
quello del rovesciamento per via rivoluzionaria del dominio del capitale sul
lavoro.